Che il passaggio ai carburanti sostenibili SAF sarebbe stato difficile lo si sapeva. Meno chiaro era quanto sarebbe stato tortuoso: ritardi nei progetti, costi eccessivi, disponibilità molto al di sotto delle promesse.
Secondo le ultime stime dell’International Air Transport Association (IATA), la produzione globale di SAF nel 2024 ha raggiunto 1 milione di tonnellate (circa 1,3 miliardi di litri), il doppio rispetto al 2023, ma ancora solo 0,3% del consumo mondiale di jet fuel. Per il 2025 la previsione sale a circa 2,1 milioni di tonnellate (2,7 miliardi di litri), appena il 0,7% del combustibile totale impiegato dal settore.

Traffico in crescita, SAF in ritardo
Se la domanda di trasporto aereo continua a salire — con incrementi percentuali già oltre il 10% rispetto ai livelli pre-pandemici, secondo IATA —, la capacità di sostituire il cherosene tradizionale con SAF è molto al di sotto delle attese.
Il ritmo attuale rende sempre più improbabile il raggiungimento dell’obiettivo del 10% di SAF entro il 2030 imposto da vari enti regolatori europei. Anche gli stakeholder più ottimisti — come molte compagnie che hanno investito su tariffe ‘green’ o sovrapprezzi volontari — stanno facendo i conti con la realtà di una fornitura limitata e un prezzo che rimane alto.

Perché i SAF costano troppo (e perchè molti li temono)
Partiamo dai prezzi superiori al cherosene: nel 2024, il costo medio del SAF è stato circa 3,1 volte quello del jet fuel convenzionale; per il 2025, IATA stima un rapporto che sale a circa 4,2 volte. Queste cifre includono ciò che in Europa si chiama “compliance fees”, cioè oneri aggiuntivi associati ai mandati di utilizzo SAF. A questo si aggiunge la disomogeneità normativa: mandati diversi nei paesi, vari gradi di obbligatorietà, requisiti di tracciabilità e certificazione che non sempre sono chiari o uniformi. Non da ultimo lo scarso supporto finanziario e sussidi: sono molte le richieste dal settore per incentivi stabili, investimenti nelle filiere, riduzioni delle barriere d’ingresso.
Un esempio concreto: l’Unione Europea ha istituito un meccanismo nel sistema ETS (Emission Trading System) che assegna quote gratuite agli operatori aerei che impiegano SAF, per compensare almeno in parte la differenza di prezzo rispetto al cherosene. Per il 2024 sono stati stanziati circa €100 milioni in quote ETS gratuite distribuite tra 53 operatori, in aggiunta ad un vantaggio fiscale equivalente a circa €25 milioni per il rating “zero” di tali carburanti.

SAF: politica in fuga
Oltre ai numeri, pesa un clima politico meno concentrato sul cambiamento climatico rispetto ai picchi del passato. In Euro-zona, come anche negli USA sotto conservatori assertivi, c’è chi rallenta o rimette in discussione normative che impongono obiettivi ambiziosi per il 2030-2050.
Willie Walsh, DG di IATA, ha più volte denunciato che
“molti mandati imposti dall’UE sono costosi e inefficaci se non accompagnati da aumento reale della produzione. I fornitori di SAF stanno imponendo “prezzi gonfiati” oltre i costi effettivi, approfittando della scarsità dell’offerta”.
Critiche che portano alla richiesta di una revisione delle politiche, affinché siano più efficaci, più giuste, e non solo simboliche.

SAF in Italia: stato dell’arte
L’Italia sta muovendo passi concreti verso una filiera SAF, ma la capacità produttiva nazionale è ancora relativamente limitata rispetto alla domanda europea. Nei primi mesi del 2025 la principale novità industriale è stata l’avvio della produzione SAF da parte di Eni (Enilive) presso la bioraffineria di Gela (Sicilia): un impianto che punta a dare un contributo significativo alla disponibilità di biojet nel Mediterraneo. Altri progetti e iniziative aeroportuali (Malpensa/Linate) e il lancio di programmi commerciali da parte di vettori come ITA Airways stanno creando mercato, ma restano vincoli su scala, costi e politica industriale.
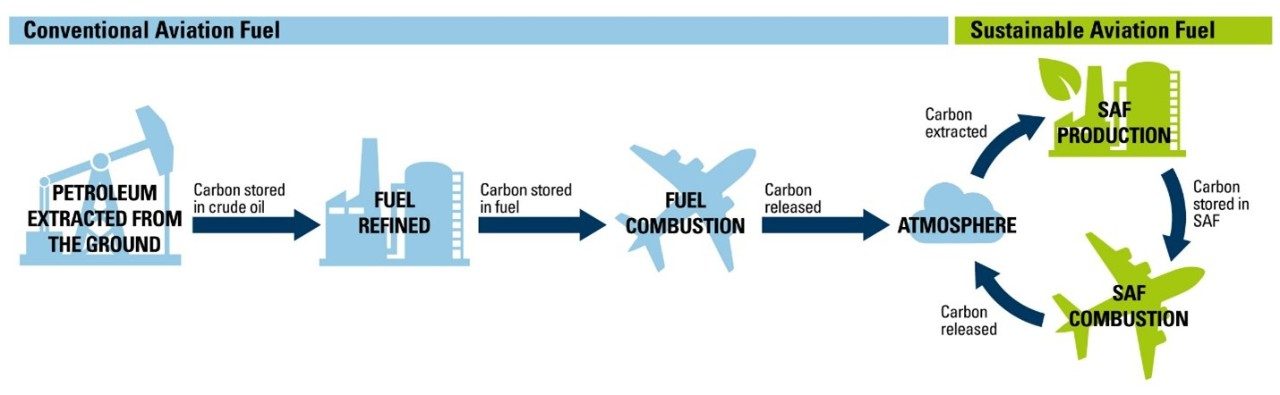
Rischi concreti per il settore
- Obiettivi 2030 a rischio fallimento — se la produzione resta sotto l’1%, il target SAF non verrà raggiunto.
- Costi maggiori per compagnie, passeggeri e aeroporti — senza sovvenzioni adeguate, il prezzo elevato impatta i bilanci e potrebbe tradursi in biglietti più cari.
- Dipendenza dalle importazioni — la produzione europea da sola non basta, molte filiere sono internazionali.
- Pericolo reputazionale e regolatorio — consumatori, ONG e regolatori chiedono azioni concrete; promesse inadempiute rischiano di danneggiare seriamente l’immagine del settore.

Qualche via d’uscita: politiche che funzionino davvero
Sono diverse le azioni che potrebbero e dovrebbero essere messe in campo a partire dall’aumento degli investimenti nelle filiere SAF, specialmente in feedstock sostenibili (oli usati, residui agricoli, rifiuti organici). Non solo, agli incentivi economici stabili, come quelli di ETS, dovrebbero aggiungersi anche sussidi diretti o sgravi fiscali.
Gli standard e mandati dovrebbero essere trasparenti e coerenti, e tenere conto della disponibilità reale e dei costi. La collaborazione pubblico-privato per costruire impianti, certificazioni, infrastrutture logistiche dovrebbe rafforzarsi.
Insomma se non si interviene con urgenza su politiche coerenti, sostegni finanziari adeguati e maggiore trasparenza, l’obiettivo del 10% entro il 2030 non solo resterà un miraggio, ma la stessa credibilità dell’industria nelle politiche climatiche rischierà di essere compromessa.
Leggi Anche: Helsinki è la città più attenta alla sostenibilità MICE, Milano scala posizioni
***
CONTINUA A LEGGERE SU BUSINESSMOBILITY.TRAVEL
Per non perderti davvero nulla seguici anche su LinkedIn, Instagram e TikTok




